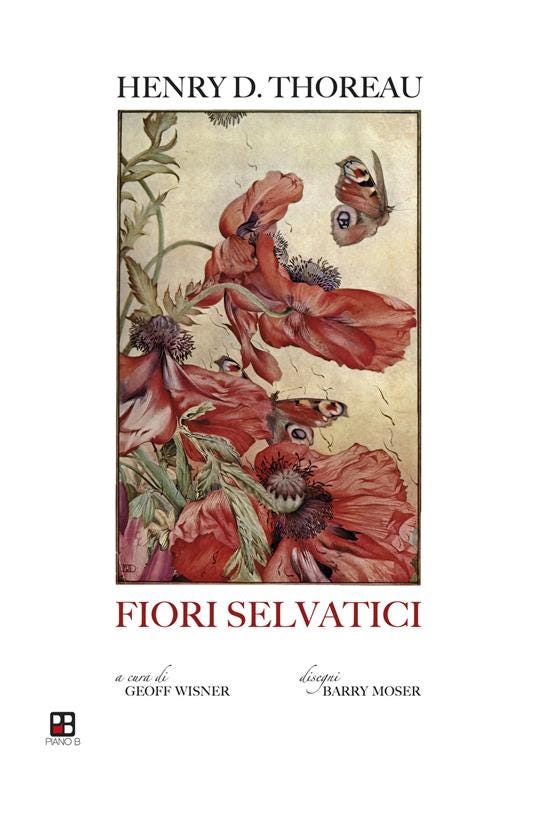Sentieri
Cosa significa vivere in natura? - numero quarantuno
Holz è un’antica parola per dire bosco. Nel bosco ci sono sentieri (Wege) che, sovente ricoperti di erbe, si interrompono improvvisamente nel fitto. Si chiamano Holzwege. Ognuno di essi procede per suo conto, ma nel medesimo bosco. L’uno sembra sovente l’altro: ma sembra soltanto. Legnaioli e guardaboschi li conoscono bene. Essi sanno che cosa significa “trovarsi su un sentiero che, interrompendosi, svia”. Martin Heiddeger, Sentieri interrotti (traduzione di Pietro Chiodi)
La luna sta diventando piena in questo momento, mentre scrivo, il suo picco è alle 19:23, e ci troviamo di fronte al plenilunio dei fiori, perché, difficile anche se viviamo in città non averlo notato, siamo nel mezzo di grandi fioriture.
Il consiglio di lettura è dedicato interamente a loro, con un autore illustre che credo chiunque ami la vita in mezzo alla natura prima o poi ha letto: Henry David Thoreau di cui è stata pubblicata di recente un’ampia selezione tratta dai suoi Journal dai titolo Fiori selvatici.
L’ospite di questo numero di Sentieri, il quarantunesimo di Braccia Rubate, è Paolo Bosca, che ringrazio per aver condiviso con noi la sua storia e le sue riflessioni sul significato della parola comunità.
Inizia a fare più caldo e forse qualcuno pensa a cosa farà quest’estate, nel frattempo chi ce l’ha si prende cura del giardino e semina: in ogni caso è un buon momento perché desideri e piante, attecchiscano e fioriscano in futuro.
Maria Claudia
Come estrarre il miele dal fiore del mondo
Nel gennaio del 1853 Henry David Thoreau colse un ranuncolo e vi trovò al suo interno un minuscolo bocciolo bianco pronto ad aprirsi: “Se ne sta assopito pazientemente, così carico di fiducia, consapevole di una primavera che il mondo non ha mai visto; è come una promessa, una profezia, e la sua forma ricorda un tempio d’oriente sovrastato da un cupola a forma di bocciolo”. La descrizione, tratta dall’Introduzione di Fiori Selvatici, pubblicato da Piano B edizioni, oltre ad essere suggestiva racchiude un tema chiave di tutto il pensiero del naturalista americano: l’idea della precognizione a cui, in questo caso, è strettamente legata la fiducia del ranuncolo.
Di fronte alla neve sciolta dell’inverno e ai primi germogli la mente può precorrere la primavera. Una predisposizione fiduciosa che anticipa le stagioni si connette alla nozione secondo cui noi scorgiamo i fiori rari solo se siamo predisposti a farlo, se coltiviamo un sentimento di anticipazione e di fiducia. Così l’animo si mette nella condizione giusta, “sono predisposto ad ogni cosa, anche strana e inusuale”, sostiene Thoreau, e aggiunge: “nel paesaggio c’è tanta bellezza visibile quanta ne siamo disposti ad apprezzare”. Non è forse così anche nella vita?
La predisposizione d’animo, la ricerca entusiasta e l’osservazione botanica sono gli ingredienti fondamentali che emergono in Fiori selvatici, il volume a cura di Geoff Wisner, che raccoglie gli scritti più belli di Thoreau, tradotti da Luca Castelletti, dedicati agli alberi, alle piante e soprattutto ai fiori incontrati durante le lunghe esplorazioni naturalistiche che impegnarono Thoreau per molti anni.
La selezione che va dal 5 febbraio 1852 al 28 febbraio 1857, impreziosita dai numerosi disegni in bianco e nero di Darry Moser, è in realtà solo un parte dell’enorme produzione dei Diari che l’autore compilò per gran parte della sua vita. Un’abitudine che seguiva il corso dei mesi e degli anni per annotare i cambiamenti del mondo naturale e del suo animo: “Eccomi, che ho tentato per quarant’anni di apprendere il linguaggio di questi campi per riuscire ad esprimere meglio me stesso”. Come per Walden ovvero Vita nei boschi, la sua opera più famosa, la ricerca di un rapporto intimo con la natura è per lui un modo per conoscersi meglio, per elevarsi spiritualmente e sentirsi parte di un Tutto.
L’esplorazione botanica constante (è sorprendente la minuzia di particolari che nota), ha permesso all’autore di avere una conoscenza approfondita e senza paragoni di moltissime specie di Concord, il distretto dove viveva, e delle zone circostanti. Thoreau conosceva almeno 400 varietà di fiori locali e la cosa incredibile è che era capace di identificare questi fiori non solo dal bocciolo, ma dalla loro fragranza. L’attenzione agli odori era viva e nei loro confronti si comportava quasi come un investigatore, tra profumi riconoscibili e aromi misteriosi.
Passano i giorni e le stagioni, tra passeggiate nei campi, attraverso i boschi, o nelle paludi: tutto è registrato sul suo diario, unendo le osservazioni scientifiche, alle descrizioni estetiche fino alle intuizioni spirituali. La selezione di Fiori selvatici costituisce una miniera d’oro per botanici, giardinieri e appassionati che non potranno rimanere indifferenti di fronte a tanta dedizione per la natura e sue bellezze, dalle minuscole alle grandi.
Maria Claudia
Io come molti sogno di vivere in natura
di Paolo Bosca
Gran parte di ciò che scriverò sarà in prima persona singolare, la mia. I miei 26 anni, le mie origini astigiane, il mio amore per Venezia e gli anni a Milano, lavorando per la casa editrice nottetempo, poi la scelta di andare a Torino a fare ricerca su due cose che amo, cibo e filosofia; la mia volontà di scrivere e di viaggiare in bici; il mio bisogno di stimoli per la mente, il gusto e il corpo; i miei affetti che danno forza; il desiderio vivo di vivere fuori dalle rotte, in un luogo amico abitato, dove avere tempo per lavorare anche della terra.
Dico questo non per particolare egocentrismo, almeno non nelle mie intenzioni, ma per far fede all’invito di un maestro che suonava più o meno così: “assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Nulla di più né di meno del vostro punto di vista sul mondo”.
Io come molti sogno di vivere nella natura[1]. Per questo motivo mi capita spesso di ascoltare storie di chi ha il mio stesso desiderio, realizzato o no. In questi racconti ho avuto spesso l’impressione che in primo piano ci fosse un rapporto individuale, quasi a tu per tu, con le cose nelle quali ci si trova immersi. Una grande attenzione alla catarsi che si prova quando ci si misura con il non umano, o con il non capitalistico, o con il non urbano – affinità e differenze. Rimane tagliato fuori da molti dei racconti e, ammetto, anche da gran parte delle mie fantasticherie, un aspetto fondamentale: la comunità. Comunità di esseri, di persone, di beni (difficile da gestire per una società che ha la fobia del bene comune), di gesti, che si realizza solo quando si sceglie di vivere “off the grid”, fuori dai reticoli, in contesti rurali. La comunità è così legata alla vita “nella natura” che una donna del Kansas, intervistata da Heat-Moon in Prateria, ne fa una questione di sopravvivenza: “In un certo senso la nostra sopravvivenza dipende da una minore riservatezza, che ci permette di partecipare di più alla vita degli altri”.
Minore riservatezza significa che molte delle cose che di solito succedono dietro le porte di casa finiscono per accadere in uno spazio attraversato anche da altri. Da quando ho avuto la possibilità di trascorrere alcuni mesi vivendo in un monolocale all’interno di una cascina abitata da altre quattro persone in un certo senso non me ne sono più andato. Perché malgrado sia stato costretto a trasferirmi nuovamente in città, a Milano, Torino, Barcellona; e malgrado tutto sia cambiato così tanto che alcune delle parole che ricordo di aver detto in quella casa mi suonano estranee; adesso ogni volta che torno a stare in un luogo del genere più che un arrivare o un andare ho addosso il senso del tornare. E non nascondo che è frustrante, come non avere le chiavi di una stanza di casa propria.
Se le cose stanno così è perché ho scoperto un senso diverso di vivere in luoghi del genere: sulla cima di una collina, in alta montagna o in una casa alle sue pendici, essere distante da tanto, vicinissimo a poco, ma così vicino da non potermi mai veramente separare. Il nome che do a tutto questo – a prendermi cura di un orto o del sentiero in un bosco, a cucinare sempre un piatto in più, ad avere sempre una parola per chi bussa e a bussare quando ho bisogno di una parola – è comunità. Ed è il solo senso profondo di ciò che chiamo vivere nella natura. Lì mi sono sentito sempre in una tenda, anche quando ero in casa, per dirla con Tim Ingold.
[1] Nonostante io sia consapevole che questa frase contiene un’infinità di problematiche credo sia utile partire da qui, come mi capita di fare nella stragrande maggioranza delle conversazioni. Col procedere della lettura compariranno dei sinonimi: vita in contesto rurale, off the grid, vita in comunità.
Non c’è ecologia senza comunità. Ecologico è il reticolo stesso che si intesse intorno a quei luoghi dove le circostanze – dall’assenza di comodità all’infinità di cose da fare autonomamente – richiedono sforzo continuo, messa in gioco e collaborazione. Non ecologico, o anti ecologico, è ciò che prescinde dai legami, una tavola piatta dove ci si incrocia per caso, come punti su un piano cartesiano fatto, magari, di cemento. Un sistema da cui ci si può facilmente sottrarre cambiando direzione. Nessun ostacolo, nessuna piazza da attraversare, nessun compito.
Non è una questione di identità, nel senso di personale percezione di sé, somma delle proprie idee e inclinazioni. Non penso che l’identità sia particolarmente importante per quanto riguarda la comunità, anzi. Comunità, cosi come natura, è qualcosa che prescinde dalle identità per fare attenzione alle pratiche, ai ruoli e alle potenzialità di ogni partecipante. Si tratta piuttosto di essere singolarità che fanno comunità senza rivendicare un’identità, “coappartenenza senza una rappresentabile condizione di appartenenza”, come scrive Agamben, a cui non sfugge la portata politica di questa relazione che non consiste in altro se non nello stare insieme perché si è qui, radicati in una certa terra, aria, in certe necessità, bisogni e ostacoli, portando con sé il peso dei dubbi inevitabili.
Solo parlando di comunità la questione della vita rurale, della scelta di vivere nella natura o di stabilirsi “off the grid” può assumere un peso politico. Non è un delirio panico individuale, non è vacanza perenne, non è fuga, solitudine. E la natura in cui si vive non è un’idea, ma un insieme di pratiche che, felice paradosso, si possono estendere ben oltre le aree rurali per schivare il facile dualismo tra città e campagna.
È utile dire anche che l’idea romantica, individualista e immersiva della vita nella natura legittima uno dei processi più dannosi per chi veramente abita in zone rurali: la mancanza di servizi. Chi ha bisogno di una scuola, di una guardia medica, o di una ferramenta quando si passa tutto il proprio tempo a osservare la crescita delle cavolacee nel proprio orto? Chi penserebbe mai alle ore di viaggio in statale per portare la figlia a scuola e andarla a riprendere? È più semplice pensare a chi vive fuori dalle zone “normali” come un macroindividuo (nel senso che può, all’occorrenza, trasformarsi da persona singola a famiglia mononucleare) impermeabile, indistruttibile, imperturbabile: finto, o meglio in una vacanza perenne, che altro non è se non una vita farlocca.
Non si vive “immersi” nella natura, ma piuttosto è proprio lì che si emerge nel mezzo di un insieme di voci, odori, temperature, grane diverse. Penso che l’idea di immersione separi più di quanto unisca. In fin dei conti per provare l’esperienza di morire la cosa più facile da fare è mettersi sott’acqua e svuotare piano i polmoni, per immergersi sempre più a fondo, a peso morto, finendo per sentirsi come una cosa nel mare. Ma se voglio vivere nella natura non è certo per morire e nemmeno per isolarmi, anzi, se è lì che mi sento più vivo è proprio perché lì, più che altrove, c’è comunità. Oggi sono sempre più convinto che vivere – veramente – è vivere in una comunità, o forse, per meglio dire, vivere una comunità a cui ci si può permettere di raccontare i fatti propri.
Questa volta ci salutiamo con la segnalazione di un profilo instagram curioso e divertente, a tema vegetale @drammaturgia.vegetale.
Invece i sassolini, i piccoli consigli di lettura di chi segue Braccia Rubate, non si sono smarriti per il sentiero ma torneranno presto!
Il prossimo numero di Braccia Rubate sarà con la luna nuova del 19 maggio, con il diario dell’orto di Barbara, gli esercizi di fantastica, le cartoline e gli ospiti. Se è il primo numero che ti arriva, puoi curiosare fra i precedenti qui e se vuoi scriverci quali sono i tuoi fiori selvatici preferiti, le tue ricerche botaniche o cosa è per te il vivere in natura e il senso di comunità, ti leggeremo volentieri: bracciarubatenewsletter@gmail.com.
Non riusciamo a vedere nulla finché non ne siamo posseduti dall’idea, e allora difficilmente riusciamo a notare qualcos’altro.
Henry David Thoreau