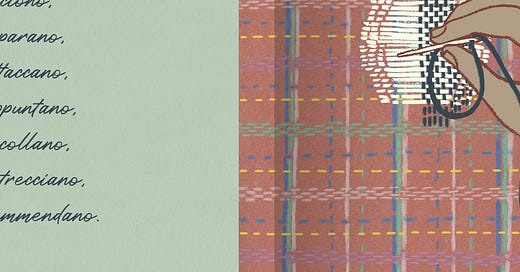La luna è nuova dalle 5.24 di ieri, 8 maggio 2024
Da ieri all’alba c’è la luna nuova: ma ieri non conta, perché c’è stata ancora la pioggia e, mentre scrivo, ne sta arrivando altra (comunque poca, ma faremo tesoro di ogni nuvola). Fra una schiarita e l’altra, con quella luce strana e provvisoria del sole fra due temporali, si va a trapiantare, si va a vedere cos’è nato in campo nel frattempo, si dividono gli spazi (che per quest’estate saranno ridotti e quindi andranno ragionati ancora di più).
Si conta quello che ha preso – quattro piante di zucchina, una fila di fagiolini, pochissimi piselli che ormai sono troppo indietro per riporci qualunque speranza, una decina di piante di pomodori, i peperoni ancora nei vasetti al riparo insieme alle melanzane, in attesa – e quello che non ce l’ha fatta: non ne farò un elenco, ho una dignità residua anch’io.
Nel numero di questo novilunio, ho raccolto dei contributi che, ciascuno a suo modo, parlano di cura, di relazioni, di scambio.
In queste settimane ho letto un libro – si chiama Con ago e filo. Un manuale per rammendare abiti, abitudini e cuori, lo hanno scritto e illustrato Sonya e Nina Montenegro e lo ha pubblicato Quinto Quarto nella traduzione di Paola Pellino – e non ho imparato ancora nessun rammendo ma ho pensato tantissimo a quanto sia esattamente questo quello che ci serve: imparare a rammendare. A ricucire, a mettere insieme quello che si è strappato, a riparare, a ricostruire invece di costruire.
A prenderci cura, degli oggetti, di noi, dell’altro, a riscoprire quanto il lavoro di cura sia necessario, e quanto invece sia stato sottovalutato rispetto a lavori rampanti che prevedono il costruire, conquistare, abbattere, progettare, inventare, scalare, aumentare, ingrandire, rinnovare, dominare; a quanto sia radicalmente femminile – e forse sarebbe da rivendicare, a questo punto, quanto un modo di vivere veramente ecologico sia anche, finalmente, femminile, o no? –, sovversivo, quanto contenga la possibilità di un cambiamento profondo attraverso gesti minimi, azzarderei a dire: amorevoli.


Nei pezzi che seguono, Martina Lo Cascio racconta delle esperienze di Contadinazioni – FuoriMercato e di Scienza Radicata, e di come non sia scontato il radicarsi nella “comunità”, di come il ruolo di ognuna all’interno di un percorso comune di lotta e cambiamento non sia immediato ma vada costruito insieme, attraverso un mutalismo che non è (solo) scambio ma cura collettiva.
Francesca Gamberini indaga invece il rapporto fra cibo, cura e ambientalismo, partendo dall’esperienza di Venissa, il ristorante di laguna di Chiara Pavan: perché il cibo non è solo atto di cura e di amore per l’altro ma può esserlo anche per il territorio e l’ambiente.
Infine c’è una lettera: la scrive il paio kota mea, in cui prova a spiegare qualcosa che è inspiegabile: il percorso di cura, di amore, di sovversione che inizia da bell hooks e che è, forse, ancora tutto da inventare.
Ma prima di iniziare, l’annuncio del mese: Alle Ortiche quest'estate organizzerà la sua prima Summer School, Habitat Rigenerati.
Si tratta di un percorso multidisciplinare di incontri, lezioni e workshop sui temi della rigenerazione urbana sostenibile, a partecipazione gratuita, che si svolgerà da mercoledì 10 a sabato 13 luglio: per iscriversi è necessario compilare questo google form entro il 10 maggio.
La difficile arte di radicarsi
di Martina Lo Cascio
Scrivere di Contadinazioni, o in generale di gruppi a cui appartengo, è qualcosa che per anni mi ha messo a disagio. Un disagio istintivo che spesso mi disgustava tanto quanto le proposte di scrittura di articoli scientifici in cui questa piccola esperienza venisse presa come caso studio o peggio ancora come buona pratica, buona a dare indicazioni di policies.
Poi negli anni queste sensazioni si sono trasformate, grazie a contesti collettivi politici e scientifici, in riflessioni metodologiche, almeno nelle intenzioni. Queste che chiamo riflessioni metodologiche nascono dall’esigenza di chiarire il posizionamento di ricercatrici e ricercatori, anche il mio quindi, dentro gruppi come il nostro che si occupano di lavoro e agricoltura contadina.
Il nostro progetto inizia a nascere nel 2013 a Campobello di Mazara (TP) simbolicamente al ghetto, dall’incontro di precarie siciliane e braccianti migranti. “Autoproduzioni Contro ogni sfruttamento” è il sottotitolo del gruppo che sin da subito è anche luogo di riflessione e azione per l’autodeterminazione alimentare guardando al tema del lavoro.
Siamo nati per lottare contro il volto più visibile e crudo dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla terra e per questo oltre a sostenere con varie attività i lavoratori migranti abbiamo prodotto negli anni olive da mensa, pomodoro secco, pesti e olio d’oliva con tecniche agroecologiche.
Nel 2020 Contadinazioni, dopo anni di attività, fallimenti, riflessioni e sperimentazioni accosta al suo nome la parola FuoriMercato che, oltre ad essere l’associazione sindacale nazionale che abbiamo contribuito a costruire sin dalla sua nascita con tante altre, è la sintesi di ciò che vogliamo essere nella prospettiva della resistenza contro (il conflitto) e la resistenza per (il mutualismo) o del mutualismo conflittuale.
Contadinazioni - Fuori Mercato nel 2020 ha come attività principali la nascita di una rete di produttrici/ori siciliane/i che è un percorso di co-progettazione e messa in comune di energia, risorse e rischi. Con Rimaflow-Fuori Mercato (Milano) e sempre più intensamente dopo la campagna “Portiamo l’acqua al ghetto di Campobello di Mazara” del 2020, ogni anno durante la raccolta delle olive abbiamo sperimentato strumenti sindacali che rispondano ai bisogni materiali e che si pongano come base di elaborazione e di rivendicazione collettive.
Un gruppo che nasce con l’ambizione di creare lavoro, di farlo collettivamente e con attenzione ai processi e ai desideri, non può che presto scontrarsi con la concretezza della sostenibilità, durata e accessibilità alle risorse materiali e immateriali. Negli anni abbiamo sempre detto e creduto che il nostro fare rete e organizzazione fosse stata la nostra risorsa principale, e ancora oggi ci è chiaro che senza la nascita dell’organizzazione sindacale FuoriMercato Autogestione in Movimento non saremmo durati più di una stagione. Quello che non avevamo messo a fuoco subito, è invece, come e quanto fosse prezioso il tempo di ricercatrici e ricercatori che spesso hanno dato continuità ad alcune attività portanti in particolare a Campobello di Mazara.
Nella mia esperienza, nei ghetti d’Italia, del Sud Europa e nord Africa ci siamo incontrate tra ricercatrici e riconosciute nella domanda su come e quanto fare ricerca fosse utile e non molestante per le persone, in particolare per i lavoratori o le lavoratrici migranti in agricoltura.
In parte alcune di noi, sicuramente nel collettivo di Contadinazioni, abbiamo risposto a questa domanda con una totale dedizione al lavoro sindacale nelle nostre organizzazioni, con le quali e grazie alle quali abbiamo anche condotto i nostri dottorati e postdoc. Questa risposta per quanto abbia da un lato appagato parte della nostra essenza di militanti e in parte la nostra coscienza, siamo sempre più consapevoli sia di fatto una scorciatoia e per questo credo e crediamo possa essere interessante rendere visibile questa inquietudine per sviluppare nuovi passi tra ricerca e attivismo.
Ecco ad oggi direi che la mia difficoltà a scrivere di Contadinazioni, grazie all’intreccio con il collettivo Scienza Radicata e con altre e altri ricercatrici e ricercatori, si sia evoluta fino al cuore della questione metodologica del come si co-produce la conoscenza dentro le lotte e a sostegno dell’agricoltura contadina agroecologica e dei braccianti. Questa consapevolezza credo sia uno degli insegnamenti più grandi per me, acquisito dentro un percorso collettivo ricco di errori, fallimenti, senso di impotenza ma anche di crescita, emozioni e autodeterminazione collettiva.
Le lotte dei braccianti e dei contadini delle reti e dell’organizzazioni che si battono per la sovranità alimentare mi hanno insegnato a posizionarmi, a pensarci interdipendenti, a pensarci in cambiamento dentro le nostre esperienze collettive, a come dis-farci per co-produrre linguaggi, metodi e visioni insieme a contadine, braccianti e lavoratrici. Per questo i meccanismi di mutualismo, che crediamo essere alla base delle possibilità di trasformazioni anche radicali, crediamo debbano anche essere da ponte tra soggettività diverse e per questo ad oggi stiamo anche dentro processi come quello di cambiare il campo che promuovono la convergenza agroecologica e sociale.
Su questo abbiamo organizzato – come Contadinazioni che prende vita con un comitato scientifico composta da me, Emilio Caja, Greta Tommesani e Luigi Conte, a Partinico (Pa), il 7 Giugno 2024, nell’ambito del festival internazionale La Nomade House – una conferenza dal titolo La scienza e il teatro radicate alla quale invitiamo artiste, contadine, scienziate, attiviste, lavoratrici della terra, migranti, educatrici con l’obiettivo di comprendere come la scienza e il teatro possano essere strumenti per il cambiamento sociale, “mettendoci in cerchio e in discussione”.
La conferenza si inserisce in un processo lungo due anni che torna a Partinico il 6 Giugno 2024 e che ha radici profonde. Esse si diffondono dalla Sicilia delle lotte degli anni ’50 e ’60 per lo sviluppo organico, per l’acqua e la pace in Vietnam - al Brasile, tra i movimenti contadini agroecologici - passando per la forza della creazione teatrale che nasce a Bruxelles, con la compagnia teatrale “Les Nouveaux Disparus”. La compagnia belga è accompagnata da associazioni, attrici e attori dalla Grecia, Francia, Germania, e Tunisia. Vi invitiamo a respirare e co-spirare insieme per sentire le radici delle lotte di emancipazione dalle mafie, dalla costrizione all’emigrazione in quanto meridionali, dalle oppressioni, dai profitti sulla libertà di movimento di ogni singolo migrante, con uno sguardo solidale e complice per il diritto alla vita, all’esistenza e alla resistenza di ogni palestinese. Partiamo da noi, dalle nostre pratiche di solidarietà e mettiamo in discussione la scienza e il teatro perché ne abbiamo bisogno per riconoscere i nostri bisogni e costruire risposte e sogni collettive.
Per fare questo partiamo da alcuni punti fermi:
1) La necessità di riconoscerci attrici di una scienza e un teatro dichiaratamente radicate e organiche ai processi che viviamo quotidianamente;
2) Le nostre pratiche, in particolare dell’associazione che ospita l’evento Partinico Solidale e Contadinazioni-FuoriMercato, di pedagogia ed ecologia politica, agroecologia e lavoro in autogestione.
Da questi punti ci muoviamo tutte insieme per comprendere come e quale co-produzione di conoscenza ci serve?
Quali forme di solidarietà troviamo tra le pratiche?
In che modo creiamo movimenti di resistenza?
_
Martina Lo Cascio è assegnista di ricerca, docente a contratto all’Università di Palermo e attivista di Contadinazioni e Autogestione in Movimento FuoriMercato. Si occupa di agroecologia, scienza radicata, lavoro migrante e agricolture nella Supermarket Revolution.
Cura, cucina, ambientalismo
di Francesca Gamberini
Volevo parlare del concetto di cura legato al mondo della cucina, dell’agricoltura e dell’ambientalismo e del potere rigenerativo dell’avere un atteggiamento materno e di cura e sono finita a leggere di Heidegger ed epigenetica. Ma partiamo dall’inizio.
Mi avevano colpita le storie di alcune donne con in comune l’amore per il loro lavoro di cuoche e di come queste storie fossero tutte caratterizzate dall’estrema cura di ogni relazione con l’ambiente circostante tanto da essere il motore di una rigenerazione di tutto l’ecosistema intorno alle loro attività.
La storia da cui sono partita, e che qui racconterò, è quella di Chiara Pavan, cuoca con laurea in filosofia che guida insieme al compagno Francesco Brutto, la cucina della tenuta Venissa a Mazzorbo nella laguna di Venezia.
Il ristorante Venissa è elegante e raffinato, ha due stelle Michelin, una rossa e la verde per la sostenibilità e offre quella che i due chef chiamano una “cucina ambientale”:
una cucina che descrive l’ambiente circostante e, allo stesso tempo, fa una riflessione sull’impronta che lascia sul territorio[1]
La tenuta all’interno della quale si trova il ristorante è un territorio fragile e complesso, la laguna è un ecosistema il cui equilibrio è messo a dura prova dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse. Chiara Pavan ha deciso attraverso la sua cucina di raccontare questa fragilità e – dunque il riscaldamento delle acque, la pesca intensiva, l’inquinamento, le nuove specie invasive, la scelta di non usare la plastica in cucina – ma anche le persone quotidianamente in relazione con quei luoghi sono parte integrante dell’esperienza e del progetto Venissa. E lo sono in maniera squisita!
Ogni piatto proposto è, per forma e sostanza, frutto prima di tutto di una riflessione e di una relazione di Chiara e Francesco con l’ambiente che li circonda e da cui traggono quasi tutte le materie prime che utilizzano. Questa attenzione, questa osservazione e riguardo per il luogo che li ospita, ha ispirato una trasformazione nel modo di cucinare ma ha contemporaneamente contribuito a rigenerare il luogo stesso.
La cucina “ambientale” di Venissa è anche ambientalista e in un certo senso attivista. E lo è proprio in virtù della cura e di una visione sistemica delle relazioni. La relazione con l’ambiente e l’ambientalismo non si è limitata alla scelta delle materie prime con la quasi totale eliminazione delle proteine animali o l’attenzione agli sprechi, ma ha anche significato costruire relazioni strette con le persone che abitano e coltivano quelle terre. Prima di tutto è stata fondamentale la collaborazione con i pensionati affidatari degli orti, orti che da quasi mille anni occupano gran parte della piccola isola, e che forniscono le materie prime dei piatti in menù. Parlare con i pescatori allarmati dai cambiamenti causati dallo sfruttamento eccessivo della pesca, dalle invasioni di specie predatorie come il granchio blu e dal clima impazzito, ha stimolato Chiara a trovare soluzioni creative per adattarsi ai mutamenti in atto.
Unendo le sue competenze a quelle delle persone che vivono quel territorio, ascoltando, osservando e studiando, è riuscita a integrare e a sviluppare il suo lavoro creando valore dagli ostacoli, riducendo l’impatto e diventando un esempio di come si può fare cucina oggi in modo responsabile e sostenibile.
La forte determinazione a volersi prendere cura dell’ambiente in relazione con il ristorante ne hanno determinato l’evoluzione e l’innescarsi di quel meccanismo virtuoso che tiene insieme ideologia, azione per il clima, innovazione e qualità del lavoro. La visione sistemica, il vivere il proprio impegno come non disconnesso dal contesto e la spinta a prendersi cura in maniera maniacale di tutti gli “ingredienti” dall’origine al piatto nel rispetto dell’ambiente, hanno portato ad un miglioramento e a una trasformazione positiva.


Ma Heidegger che c’entra con la storia di Chiara Pavan a Venissa?
Quando voglio afferrare il significato profondo del concetto che una parola porta con sè, parto sempre dall’etimologia e dal senso che via via le è stato attribuito.
Alla voce cura del dizionario etimologico scopro che le radici proto-indoeuropee *kʷeys e*(s)kewh₁- significano "fare attenzione, guardare" e, "osservare, guardare, prestare attenzione" e da queste derivano parole come curioso, sicuro, incuria ma anche l’inglese show e il tedesco schauen, cioè “guardare, vedere”[2]
E ancora tra le definizioni di cura si legge: sollecitudine, grande ed assidua diligenza, vigilanza premurosa, assistenza, grave e continua inquietudine, affare, negozio, tutto ciò che sollecita e richiede vigilanza.
La cura ha radicato nel suo significato profondo il concetto di relazione, osservazione, contatto con l’altro. Osservazione e relazione che muove ed è motore di attenzione e protezione – un luogo sicuro è quello dove non dobbiamo curarci dell’osservare e vigilare perché ne conosciamo i pericoli e le caratteristiche.
Interessante anche in greco antico che per la parola cura utilizza ἐπιμέλεια che si traduce come un «intervento orientativo e promotivo volto a far fiorire l’esistenza dell’altro».
E finalmente arrivo ad Heidegger.
Indagando ancora sul significato della parola cura ho trovato che Igino detto l’Astronomo, scrittore romano del I secolo, in una delle sue Fabulae[3] parla proprio della Cura e che Heidegger ha analizzato quella favola che racconta l’origine dell’uomo, in uno dei suoi saggi più importanti Essere e Tempo. Nella favola è Cura che con dell’argilla modella l’Uomo, è dunque attraverso quell’osservare, guardare, prestare attenzione che l’Uomo prende forma, si definisce nella relazione con l’altro da sé. La favola si conclude con la sentenza di Saturno che dice a Cura che accompagnerà l’Uomo per tutta la vita. Il filosofo tedesco definisce la cura come caratteristica fondamentale dell’essere umano che è di per sé in relazione con l’ambiente che lo circonda e attraverso la cura è essendo.
Prendersi cura significa quindi osservare attentamente l’ambiente in cui si vive per creare in ogni relazione con esso il benessere proprio e dell’ambiente stesso. Se non ci fosse la relazione intesa come cura non ci sarebbe vita.
E l’epigenetica?
L’epigenetica, scienza che osserva i cambiamenti nell’espressione genica che non alterano la sequenza del DNA, è un’altra faccia della stessa storia, la relazione come cura. Ci sono sempre più studi che confermano che chi siamo non sia determinato esclusivamente dalla sequenza dei nostri geni ma anche dalla relazione con l’ambiente in cui viviamo. Che la predisposizione e la possibilità di sviluppare o meno alcune caratteristiche sia influenzata anche da altri fattori esterni a noi. La sequenza del DNA, pur rimanendo la stessa, si esprime diversamente in relazione alle influenze dell’ambiente e ci determina tanto quanto i geni.
In conclusione l’ambientalismo può essere interpretato, e potrebbe essere raccontato, come quell’azione di cura dell’ambiente e delle relazioni con esso, che si orientano allo sviluppo delle migliori espressioni delle sue potenzialità. La cura come cura.
_
Francesca Gamberini è specializzata in Storia e Cultura dell’alimentazione, lavora da venticinque anni a diversi livelli nel mondo della ristorazione, della comunicazione e degli eventi enogastronomici. Dalla gestione di una attività propria è passata alla consulenza a chef, ristoranti e agenzie per la costruzione di strategie di comunicazione e marketing e la progettazione di eventi e rassegne culturali. Ora lavora nella prima food coop in Italia ed è attivista di Terra! associazione ambientalista che si occupa di filiere agroalimentari.
[1]
https://www.venissa.it/
[2] •
https://www.etimo.it/?term=cura
(sostantivo) dal latino arcaico coira, coera, che i grammatici latini riconducevano a cor, "cuore" ma che secondo le teorie più moderne (cfr. Pianigiani) è piuttosto riconducibile alla radice del proto-indoeuropeo *kʷeys-, "fare attenzione, guardare", da cui anche l'aggettivo curiosus, oppure dalla radice *(s)kewh₁-, "osservare, guardare, prestare attenzione", dalla quale discendono il verbo caveo, ed anche il sanscrito कवि (kaví), "saggio"; il greco antico κοέω, "sapere, essere a conoscenza di"; il lituano kavoti, "proteggere, accudire"; ed attraverso la radice germanica *skawwōną anche l'inglese to show, "mostrare" o il tedesco schauen, "guardare, vedere". Con ogni probabilità l'inglese care non è invece correlato
Tutto ciò che richiede vigilanza
Deriv: curioso, incuria, sicuro
Sicuro: se disgiuntivo, di luogo che non presenta pericoli, difficoltà, dubbi
[3] La “Cura”, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La “Cura” lo prega di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri. Ma quando la “Cura” pretese imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle fosse imposto il proprio. Mentre la “Cura” e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione: “Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive lo possieda la “Cura”. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di humus (Terra). Pagina 282-283 Essere e tempo Martin Heidegger Oscar Mondadori 2014
Lettera a tu
di kota mea


Carə tu,
mi chiedevo quando e come è natə kota mea.
Non c’è un tempo e uno spazio in cui è natə.
È natə insieme a noi o prima di noi?
Ci sopravviverà come unə figliə?
Questo non lo so.
Quello che so, e che sappiamo entrambi, è che kota mea nasce da una frase magica, meravigliosamente semplice: «healing is an act of communion». Per essere precisi, la frase per intero dice: «Rarely, if ever, are any of us healed in isolation. Healing is an act of communion».
È stata scritta da bell hooks e si trova nel suo libro più celebre: All about love. New visions.
Da questo seme nasce kota mea, più come una pianta che come unə figliə.
Mentre scrivo queste righe mi viene in mente anche un’altra frase importante per noi, che abbiamo sentito insieme durante una lezione di antropologia: «ci sono malattie inguaribili ma non esistono malattie incurabili». La professoressa voleva sottolineare la differenza tra ‘guarigione’ e ‘cura’, e forse anche tra due mentalità diverse, due poli opposti da cui osservare la malattia: la guarigione vista come risoluzione definitiva della malattia (come è tipicamente intesa nella medicina occidentale, se la approcciamo in modo estremamente moderno e anche superficiale) e la cura che invece diventa un perpetuo prendersi cura, individuale (del proprio corpo, del proprio spirito, eccetera) e insieme collettivo (indicando perciò, in questo caso, una mentalità che ricorda piuttosto la medicina delle diverse tradizioni orientali, più improntata alla prevenzione).
Quando ci siamo incontrati eravamo molto malati – e lo siamo ancora, se vogliamo essere onesti – ma tramite l’incontro abbiamo potuto scoprire e riscoprire come, prendendoci cura l’uno dell’altra, sia forse possibile guarire. Dove ‘guarire’ – attenzione – non significa risolvere alcun problema, semmai vuol dire attraversare i sintomi, ascoltare il dolore, imparare dal proprio dolore, mettersi faccia a faccia con la morte.
«Sono morto...», così nasce uno dei testi che abbiamo portato sempre con noi, durante i nostri atti curativi; un breve componimento che René Daumal ha scritto negli ultimi mesi della sua malattia (un altro esempio magniloquente e tenerissimo di malattia inguaribile che trova il suo senso nella cura della collettività, della relazione, della reciprocità).
Ecco, forse kota mea nasce da una semplice domanda: possiamo davvero guarire insieme prendendoci cura, di noi come individui e dell’altro come parte di noi?
Ci siamo chiesti se possiamo guarire insieme attraverso la cura. Io penso – o meglio: sento – che sì, possiamo. E che, anzi, è l’unico modo possibile per sopravvivere all’assalto dei tempi in queste macerie d’umanità. Ma non solo noi due. Tutti. E non solo possiamo: dobbiamo farlo.
Il desiderio di portare anche ad altri queste domande, questi processi interiori – come si può portare di domenica mattina, con un fremito dentro al cuore, un mazzo di fiori al proprio amato – ha fatto sì che kota mea potesse iniziare a sporgersi al di là della sfera privata, aprendo una condivisione che sfocia nell’arte, nel rituale e nello stare assieme come comunità. O meglio, sono state queste stesse dimensioni ad affacciarsi a noi, come se pian piano tutto concorresse verso la nascita di questa nuova entità. Siamo stati, allora, travolti da una sincronicità dopo l’altra, e non abbiamo potuto non seguire la strada che ci veniva svelata. A ogni passo.
Ricordo, dopo qualche mese dal nostro incontro, una conversazione con una nostra amica. Le avevo confidato che in quel periodo mi sembrava stessi dedicando tutte le mie energie alla relazione, e di non star facendo molto altro. Lei, col suo fare sempre secco e perentorio mi fa: «eh, ma guarda che le relazioni sono una parte importante nella vita di una persona!». La semplicità e la verità della sua risposta mi aveva spiazzata, e non seppi controbattere.
Spesso, quando va bene, le relazioni si riducono a fare da contorno al piatto principale della nostra vita, ossia: me stesso, il mio individualismo e la mia carriera lavorativa da portare avanti. Se gli altri rientrano in qualche modo all’interno di questo piano, e se non minacciano di fermare o anche solo rallentare il treno in corsa dei miei obiettivi individuali, bene: solo allora, sì, ci si può incrociare frettolosamente qui e lì tra le varie cose, altrimenti ci si mette poco a salutarsi e dirsi addio.
Ritornare ogni giorno alla centralità delle relazioni (si badi bene: non solo quelle romantiche), e dell’altro, ci sembra sempre più un atto rivoluzionario. Per tornare davvero a riconoscere l’altro per chi è, non più come un mero fattore del sistema capitalistico da cui prendere qualcosa a nostro beneficio, un altro fulcro nel cosiddetto network sociale, un altro prodotto a servizio dei nostri schemi (come ci dice Kae Tempest in On Connection: «When we are fixated on what we can get from an exchange, or how we can benefit, instead of considering what we can offer, we are being exploitative. This fixation can be so intrinsic, we imagine ourselves innocent of it. Unintentional exploitation is exploitation, none the less»). In tal senso, ci sembra che tornare – o comunque provarci – a curarsi delle relazioni possa rivelarsi, oggigiorno, rivoluzionario. E questa è certamente una delle cose che kota mea vuole fare: allenare quell’attitudine, individuale e collettiva, a spostare la nostra attenzione dal sé all’altro, o meglio: a cosa c’è tra il sé e l’altro. Fuori da me. Fuori dai miei vortici e dalle mie limitanti narrazioni. E farlo attraverso un linguaggio artistico. Perché è proprio questo spostamento che ci consente di aprirci all’incontro, come ci dicono i preziosi insegnamenti della filosofa Luce Irigaray: «Il disvelamento dell’altro come tale può accadere solo in un ritrarsi del mio progetto su di lui, che lo lasci manifestarsi come quello che è. L’altro non può avere luogo nel mio proprio mondo. [...] Curarmi dell’altro equivale dunque, in parte, alla sospensione delle mie proiezioni o progetti su di lui».
Ma chi è l’altro?


Mesi fa, proprio mentre mi interrogavo sull’alterità nell’ambito dell’ecosomatica, tu ricevevi la proposta di organizzare un laboratorio di Deep Listening, proprio in collaborazione con la pratica dell’ecosomatica. Gli interessi iniziavano a intrecciarsi in maniera organica e magica, e di lì a poco abbiamo ideato, in collaborazione con le artiste Diana Lola Posani e Signa Schiavo-Campo, quello che oggi è Naturale Sconosciuto: un ritiro residenziale di Deep Listening ed ecosomatica. Con Naturale Sconosciuto vogliamo focalizzarci sulle relazioni che intratteniamo con suono, corpo e ambiente naturale. E cercare di coltivare questi campi relazionali, mettendoci in ascolto, non solo con l’udito ma con tutto il corpo-mente, per favorire l’accadimento di un incontro con l’altro da sé. «In questo momento stai ascoltando? / In questo momento stai ascoltando quello che senti? / Mentre ascolti, stai sentendo? / Mentre senti, stai ascoltando?» (Pauline Oliveros, Deep Listening).
Se con il Deep Listening, espandendo l’ascolto all’intero continuum spazio-temporale del suono, facciamo esperienza diretta dell’«essere connessi alla totalità dell’ambiente che ci circonda, e a qualcosa di ancora più vasto» (Pauline Oliveros, Deep Listening); allo stesso tempo, l’ecosomatica ci consente di tornare ad ancorarci nel corpo, il ché implica tornare a sentirsi a casa: dunque tornare anche nel corpo della Terra, nella nostra casa più grande, situati nel nostro posto. Come ci dice Signa, «l’invito è di sperimentare cosa vuol dire essere corpi estesi della natura: come possiamo riconnetterci con un senso profondo di sorellanza e di fratellanza, non solo tra noi come comunità e come gruppo umano ma anche con tutto l’ambito dell’oltreumano».
Il primo ritiro di Naturale Sconosciuto avrà luogo dal 17 al 19 maggio sul Monte Soratte, a un’ora da Roma, e ne seguirà un secondo a fine ottobre 2024.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle origini. La prima traccia della scritta kota mea appare proprio sul frontespizio del libro Tutto sull’amore di bell hooks. L’hai scritta tu, a matita: al centro, in grande, KOTA MEA; e sotto, più piccolo PRIMI 100 GIORNI. Quando mi hai regalato quel libro, quella scritta era già pregna di senso, un senso che ancora non comprendevo; che avremmo, però, scoperto insieme dopo vari mesi. E che stiamo ancora scoprendo con il nostro progetto più ‘performativo’ che unisce i nostri background tra danza, scrittura, meditazione, e il mondo rituale dell’invisibile che – va detto – è il vero artefice del nostro incontro.
Se ci ripenso è molto particolare il modo in cui ci siamo incontrati, tre volte prima di sceglierci: la prima volta nel mondo sottile, poi l’abbiamo attraversato insieme quel mondo invisibile, in un abbraccio infinito, tramite una morte e una rinascita – come da tradizione – durante una cerimonia epica e senza tempo, il cui ricordo mi fa ancora venire la pelle d’oca.
Infine, ci siamo ritrovati nel corpo.
“Cos’è l’invisibile?”: una questione che mi ha ossessionato per molti anni.
Per rispondere a questa domanda voglio rievocare un’altra cerimonia, un altro rituale, molto diverso. Un Temazcal davvero speciale che abbiamo fatto insieme un po’ di tempo fa. Ricordo le parole di Odon, l’uomo di medicina che ha condotto la cerimonia. prima di entrare nella capanna: dopo tanto tempo passato a giocare con le nuvole, è tempo di mettere radici, di scendere dal cielo e piantare i vostri pensieri, i vostri voli pindarici, nelle profondità della terra. Da quel giorno sono passati mesi, abbiamo dovuto affrontare insieme la malattia, e poi ci siamo finalmente arresi alle parole di quell’uomo di medicina. Odon aveva visto, nell’invisibile, le potenzialità già realizzate di ciò che stavamo covando dentro, di quello che stava crescendo, del seme che portavamo in noi.
A un certo punto è stato molto chiaro di cosa fosse fatto il seme di cui parlo.
In questo momento si chiama ABOUT LOVE – atti curativi di sovversione.
È molto difficile definire cosa sia, e forse non è nemmeno utile. Abbiamo provato a riassumerlo dicendo che si tratta di un ibrido, tra performance, laboratorio e trattamento, ma ad oggi aggiungerei che si tratta anche di un rituale, di una cerimonia, un’esperienza di cura compartecipata, intima e aperta agli accadimenti del momento.
Immaginiamo una grande stanza, col fuoco acceso; vi si accede solo da bendati e si viene accompagnati nel buio fino al proprio giaciglio, dove ci si può stendere al calduccio, comodamente avvolti da una coperta. Una voce ci guida verso l’altro mondo e così comincia la magia. Si scrivono lettere, si leggono libri, si danza, ci si riconnette al proprio sé – tramite il proprio corpo, agli altri. Si cerca semplicemente di guarire insieme, come suggeriva bell hooks; e davanti al fuoco, come insegnano gli sciamani che abbiamo avuto la fortuna di conoscere insieme.
Da quando abbiamo ideato ABOUT LOVE – atti curativi di sovversione è successo di tutto, ogni occasione chiamava un nuovo incontro attraverso una sincronia precisa ed eloquente.
In principio siamo stati da Ex Rugiada, un piccolo spazio accogliente proprio sotto casa. E lì abbiamo innanzitutto inaugurato lo spazio con una piccolissima performance: Amore subacqueo. Delle letture da Undrowned. Lezioni di femminismo Nero dai mammiferi marini di Alexis Pauline Gumbs, che accompagnavano un’improvvisazione che non ho mai potuto vedere, tua. Di sottofondo i canti delle balene. È stato un germogliare timido, ma nel quale c’era già tutto. Undrowned era un libro che avevamo letto insieme e incarnava perfettamente quello che vorremmo dire con ABOUT LOVE. Amore subacqueo infatti cominciava così:
Guarda. C’è qualcosa sopra a tutto questo che ci ha portato qui, insieme. Riesci a vederlo? Riesci a sentirlo? E il cielo è abbastanza grande da contenere tutto ciò che non ha senso in te e in me in questo momento. Qui, sulla riva, il cielo bacia in un solo bacio la terra e l’orizzonte. A volte mi sforzo di vedere l’invisibile, quest’aria che mi sostiene in ogni caso. Ma che luogo perfetto per studiare tutto ciò che non ha vincoli: qui, sulla riva del mare, dove tu metti alla prova i miei limiti ogni giorno. E amarti potrebbe essere il movimento che darà forma alla mia lunghezza, alla nostra forza. E sì, a volte devo gridare i miei limiti. Anche tu. Ora, però, smettiamola e torniamo a respirare il cielo. (Alexis Pauline Gumbs, Undrowned)
C’era già tutto, visto?
Ma ricapitoliamo comunque, come un esercizio di integrazione:
sempre da Ex Rugiada, abbiamo poi tenuto alcune sedute individuali dei nostri atti curativi.
Delle persone speciali, con una generosità a volte commovente, si sono lasciate guidare in un viaggio dedicato a loro e a noi. Una catabasi d’amorosi sensi. Una ierogamia interiore. Per circa due ore, a uno a uno, li abbiamo avvolti con la voce, con la danza, con gli oracoli, con il tatto e l’ascolto. Ci siamo curati a vicenda.
Nel frattempo, in questo sincronico concatenarsi di eventi, siamo stati invitati a fare una residenza artistica da Pianeta Soma, a Miglieglia, in Ticino. In un posto del cuore, animato da una meravigliosa Margherita Tassi che ci ha accolti e sostenuti durante un processo lungo una decina di giorni, cui è seguito un rituale, assieme a un gruppo di sette anime coraggiose. Un momento di impressionante vicinanza tra sconosciuti. Un rituale mistico, un ritorno a casa. E una cerimonia di cura, quasi sciamanica, un’immersione nel mistero ancestrale dell’invisibile.
Quei giorni sono stati estremamente difficili, come difficile è l’amore.
Ogni giorno ci svegliavamo e: potevamo iniziare subito a litigare, per poi entrare in sala; oppure cominciare a litigare solo dopo essere entrati in sala. Quello che accadeva poi in quei settanta metri quadri era un magmatico mescolarsi di alterità, di sudore, di urla disumane e corpi che si trascinano da una riva all’altra dello Stige. Così, ogni giorno. E proprio quando sembrava tutto risolto, grazie a dei piccoli maestri che ci hanno mostrato la via con la loro saggezza invereconda, tutto è crollato nuovamente nel caos. Una tempesta, fino all’ultimo giorno.
Le ore precedenti al nostro rituale ogni cosa sembrava instabile, tutto era messo in crisi. Eravamo impreparati, rancorosi e impauriti. Eppure, abbiamo fatto questo salto nel vuoto (in questo il sostegno di Margherita e la sua fiducia, i suoi consigli, la sua vicinanza sono stati fondamentali). Il salto nell’invisibile è stato davvero come una lunga meditazione, un sogno, un volo magico. Sapevamo esattamente cosa fare.
Durante quei giorni ci hanno accompagnato alcuni libri, che avevamo portato con noi. Mi ha colpito che alla fine della cerimonia i partecipanti abbiano chiesto la bibliografia. Mi ha fatto pensare a un altro maestro spirituale che abbiamo incontrato insieme: Padre Gianni, il priore di Fonte Avellana. Un giorno davanti a una antica Bibbia poliglotta, mi ha chiesto: «a cosa servono i libri?», «possono servire per tante ragioni diverse», ho risposto. «Soprattutto servono per guarire», ha controbattuto lui, «per questo sopra la porta di questa biblioteca c’è scritto pharmacopolium che vuol dire farmacia». Ed è in quel momento che mi è tornata in mente – con un effetto matrioska – la mia insegnante di kundalini, Prem: «tu hai molti otto nella tua data di nascita, che è il numero del guaritore», «ma io non pratico nessuna forma di guarigione», «tu guarisci con i libri, non ti sembra?» mi ha risposto lei, sorridendo beffarda come suo solito. Da quel giorno ho spesso usato i libri come fossero i Tarocchi o i Ching, aprendo le pagine come si apre un mazzo di carte.
E in questa lettera voglio onorare, ricordare e ricapitolare i libri che ci hanno accompagnati fin qui, e che si sono presi cura di noi, condividendoli perché possano guarire anche altri amici e amiche:
bell hooks, Tutto sull'amore. Nuove visioni (il Saggiatore)
Alexis Pauline Gumbs, Undrowned. Lezioni di femminismo Nero dai mammiferi marini (Timeo)
René Daumal, Il lavoro su di sé. Lettere a Geneviève e Louis Lief (Adelphi)
Ibn ‘Ata’ Allah, Sentenze e colloquio mistico (Adelphi)
Julio Cortázar, Le ragioni della collera (Fahrenheit 451)
Lucia Palladino, entrare nel bosco. o come praticare l'anticapitalismo (NERO)
Sara Gamberini, Maestoso è l'abbandono (Hacca)
Boris Groys, Filosofia della cura (Timeo)
Platone, Simposio (Adelphi)
Il Cantico dei Cantici (Adelphi)
Simone Weil, La persona e il sacro (Adelphi)
David di Dinant, Mente Materia Dio (il melangolo)
Clarice Lispector, Acqua viva (Adelphi)
Georg Simmel, Sull'amore (SE)
Osho, L’amore nel tantra (SE)
Fernando Pessoa, Poemetti erotici (Passigli)
Oltre ai libri e alle parole, ci hanno accompagnato il corpo e il movimento e, ovviamente, il fuoco. Siamo stati nella parola o nel corpo, a volte scegliendo consciamente, a volte no. A volte intrappolati in una rigidezza tutta razionale, e altre volte liberati da delle lunghe improvvisazioni che portavano a galla tutto quel che c’era da vedere, così da potervi respirare dentro con grazia o con furore.
Dopo dieci giorni allo spazio La Florìda in Svizzera, sono tornata a Roma frastornata, il mio corpo ha rilasciato tutta l’intensità del lavoro ‘fatto’, o attraversato, e sono sprofondata inaspettatamente per due giorni nei miei abissi interiori, a scavare, senza ragione; a fissare per ore l’improvviso intorpidimento del mio essere che aveva deciso di tornare – più forte di prima – nella cara vecchia oscurità. Era una fase di integrazione?
Al quinto giorno di residenza ti ho chiesto, con sfrontatezza: «che ci siamo venuti a fare in Svizzera?». Non avevo ancora capito la reale motivazione del nostro approdo sul Pianeta Soma. E, addirittura, al settimo o ottavo giorno – non so, ho perso il conto – ho scoperto, mio malgrado, che quello che stavamo tentando di fare non era, a tuo dire, nemmeno un “progetto artistico”. Come se volessi, a tutti i costi, sminuire, mettere da parte il livello artistico della nostra inconsapevole spedizione oltrefrontiera.
Travisavo il senso delle tue parole, e forse, anche il senso del nostro progetto.
Abituata a lavorare a progetti artistici nell’ambito della danza contemporanea (e spesso all’interno di tempistiche ristrette dettate dall’ormai nota produttivizzazione dell’arte che rischia di succhiare via l’anima di qualsivoglia pulsione creativa) portavo in sala un desiderio di produttività e di struttura, e una necessità di “provare”, perché potessero guidarci nei giorni della residenza. E ogni volta questo mio proposito veniva sfaldato dal ‘qui e ora’, che si rivelava sempre più potente: un maestro inascoltato che cela gemme rare ma anche bei muri in faccia.
Ci siamo interrogati sul significato del “provare”: cosa voleva dire nel nostro caso “fare le prove”? Come ci si prepara per una performance? E come, invece, per un rituale? Qual era la chiave necessaria ad aprirci – entrambi – affinché l'atto curativo potesse manifestarsi? Abbiamo dovuto sovvertire tanti pattern, lasciarci rimescolare nella melma più oscura, attraversare tutto il nostro futuro in una visione lunga qualche ora, e ribaltare tutte le assi interiori che fino a quel punto avevano definito il nostro stare al lavoro e alla relazione, per cercare – spesso a tentoni, e certamente non come una decisione presa a tavolino – una metodologia di lavoro che non solo facesse da comune denominatore tra le nostre attitudini individuali, ma che fosse anche la ‘giusta’ metodologia per questo progetto (che non so più nemmeno se sia giusto chiamare progetto).
Per kota mea c’è sicuramente ancora tanto lavoro da attraversare per raggiungere quell’equilibrio labile tra l’ascolto di ciò che è necessario nel momento (anche se sembrerebbe portarci fuori rotta) e la pianificazione razionale delle pratiche da portare avanti. Tra il femminino e il mascolino. Tra l’intuizione e l’azione. Ma qualcosa è successo quella sera, il venticinque aprile, durante la “restituzione al pubblico” del nostro lavoro residenziale. La tua voce non era la stessa. La voce del fuoco, la stanza e l’aria che ci riscaldava il viso, nemmeno. La mia danza era diversa; era diventata un’oscillazione tra i mondi, a servizio non solo di chi guardando la esperiva, ma a servizio proprio di quel mondo che chiedeva, nel silenzio, di emergere, e che mi muoveva (come nella danza Butoh, non ero io a muovermi, ero, piuttosto, mossa da – being moved by o danced by). Infatti, se da un lato «nella danza si penetra nella coscienza del corpo, nell’energia della materia» (Virgilio Sieni, Danza Cieca), essa stessa, con il suo linguaggio di transitorietà ed evanescenza, si spinge oltre la sfera del tangibile, aprendosi all’invisibile che il danzatore attraversa, momento per momento, con le tracce dei ‘suoi’ movimenti. Il movimento genera così una presenza espansa, che vive oltre il corpo.
Quei quattordici occhi divenivano parte del nostro mondo e noi parte del loro. Tutti ci dissolvevamo, in quel momento, nell’esperire se stessi e l’altro nell’incontro, non solo l’osservato e l’osservatore, separati. Uno, tutto. Come in un tempio. Proprio come scrive Lucia Palladino in entrare nel bosco: «per incontrare l'altro da me devo entrare nel tempio (templum), devo andare in quel luogo dal quale è possibile percepire ciò che non è uguale a me. Devo dislocare me stessa fino al punto in cui non è a proposito di me né a proposito di te, ma di qualcosa che non sappiamo ancora nominare. [...] Il templum è un taglio nello spazio e nel tempo».
Per sua natura, ABOUT LOVE – atti curativi di sovversione intesse tra loro vari livelli: il livello personale e relazionale, quello artistico della performance, del laboratorio, il livello di cura, del cerchio, della condivisione, della lettura, del corpo, della parola; livelli che si possono riassumere in tre sfere: sfera individuale; sfera relazionale-comunitaria; sfera artistico-performativa.
All’interno di questo fitto tessuto, il partecipante/spettatore diventa parte integrante del nostro procedere, e si fa esso stesso agente di cura verso sé stesso e verso il resto del gruppo-mondo.
Così, come sulle montagne russe, tra il caos, l’entusiasmo, la nausea, lo sconforto, i viaggi nell’altrove, le pazzie, le contemplazioni: abbiamo proseguito. Stando in quell’odioso, eppur sacro, non-sapere fino all’ultimo. E solo poco prima della nostra ripartenza verso casa abbiamo realizzato di essere solo dei naufraghi, proprio mentre scrivevamo i nostri ringraziamenti a Margherita: «Cara tu, grazie. Grazie per aver creduto nel vento che ti ha portato a casa questi due naufraghi dal sud, [...] Sarà grazie a te se forse torneremo a casa». Ecco, forse passo dopo passo stiamo tornando a casa. Insieme. E – speriamo – insieme a tutti voi.
Questə è kota mea, adesso.
_
kota mea è un duo, un paio.
Un binomio artistico che porta avanti una ricerca prevalentemente transdisciplinare e transmediale, collettiva, esperienziale e volta alla guarigione reciproca. Tramite l’esplorazione della zona liminale che si forma nell’intreccio di arte, consapevolezza e cura di sé, il lavoro di kota mea si propone in forma di incontri ibridi, rituali dove si mescolano diverse tecniche e s’invertono i ruoli di chi guarda e chi dev’essere guardato, per provare a raggiungere una modalità espressiva il più possibile trasversale e autentica.
Bartolomeo Cafarella ha pubblicato racconti, articoli e saggi su diverse riviste e giornali. Si occupa soprattutto di filosofia dell’animalità, antropologia, storia delle religioni e tradizioni native.
Maria Concetta Cariello si dedica all’arte del movimento, come performer, coreografa ed educatrice di danza contemporanea a indirizzo somatico; e alla pratica olistica.
Anche per stavolta è tutto: grazie.
Braccia Rubate torna con Sentieri, l’edizione del plenilunio a cura di Maria Claudia, il 23 maggio.
Se ti va, scrivi a bracciarubatenewsletter@gmail.com: raccontaci come, di e con chi ti prendi cura.
Buona sovversione,
Barbara